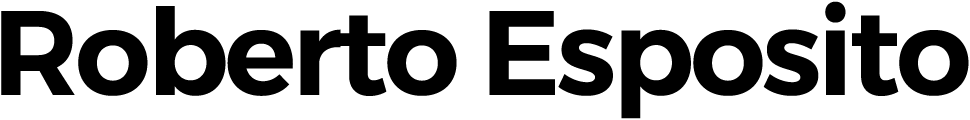Giovedì scorso ho trovato un nuovo amico.
Non conosco il suo nome però, quando si è fermato ad un metro da me per sorridermi senza motivo, immobile e con entrambe le braccia stese lungo i fianchi, ho capito che avrebbe potuto contare su di me.
Credo che abbia più o meno 40 anni, portati male. Un metro e sessanta, capelli neri e lunghi baffi, camicia hawaiana e un passaporto indecifrabile tra le mani, blu con scritte dorate in bassorilievo. Dall’aspetto e dal colore della sua carnagione ho immaginato che fosse pakistano fino a quando, indicandosi il petto con una mano, non ha cominciato a dirmi “Ai India, Ai India, Ai India, Ai India, Ai India, Ai India, Ai India, Ai India, Ai India, Ai India, Ai India, Ai India, Ai India” ripetendolo per questo esatto numero di volte.
Così, dopo aver tentato invano di parlare, è rimasto in piedi di fianco a me con le mani unite, senza dire una parola. E siamo stati lì almeno 15 minuti: io fermo per i fatti miei e lui ad un metro, leggermente più indietro, a guardarmi e guardarsi intorno sorridendomi solo quando mi voltavo verso di lui. Non appena ho raccolto lo zaino per avviarmi sul treno, lui si è precipitato a prendere la sua valigia e poi, con passo svelto, mi ha raggiunto e si è messo a camminare al mio fianco. Arrivati in carrozza, sono scalato di qualche posto per arrivare al finestrino e gli ho fatto segno di via libera, lasciandogli intendere che poteva venirsi a sedere senza timore di disturbarmi.
Piedi stretti, schiena dritta e mani sulle gambe. Di tanto in tanto gli lanciavo un’occhiata ma mi scappava da ridere senza motivo. Lui invece un motivo per sorridere ce l’aveva e stava lì ad osservarsi intorno a 360°, scrutando da entrambi i lati, poi a terra e infine al soffitto. E continuava a sorridere emozionato, oscillando un pò la testa come un bambino in viaggio verso Disneyland o come me quando atterrerò al LAX.
Entrambi aspettavamo l’occasione giusta per iniziare a parlare ma, appena pronunciata la prima frase, ho capito immediatamente che non conosceva neanche una parola di italiano nè di inglese. E ovviamente lui ha iniziato a discutere nella sua lingua madre come se fossimo stati davanti ad un bar e soprattutto come se io avessi avuto almeno una vaga idea di che lingua stesse parlando. In un modo o nell’altro è riuscito a farmi capire la sua destinazione, così mi ha chiesto di avvertirlo quando sarebbe dovuto scendere. Gli ho risposto di non preoccuparsi, che me ne sarei occupato io. Poi è riuscito a dirmi che il suo cellulare era quasi scarico: dopo qualche minuto infatti, ha tirato fuori una penna e ha cominciato a scriversi alcuni numeri sulle mani, in modo da poterli chiamare anche se il telefono si fosse spento.
Gli ho fatto segno di fermarsi un secondo, ho aperto lo zaino e lui ha allungato la testa, curiosissimo di vedere cosa stessi per tirare fuori. Così ho strappato e gli ho regalato una pagina del mio libro di Tecniche di Simulazione di Volo, facendogli capire che poteva usare quella al posto delle mani per appuntarsi i numeri. Quando gli ho detto che sarebbe dovuto scendere, lui ha preso tutti i suoi bagagli e poi è rimasto lì a ringraziarmi fino a qualche secondo prima che le porte si richiudessero. Ripetendo qualcosa di indecifrabile seguita da Thank you, mi ha così insegnato che nella sua lingua Grazie si dice धन्यवाद.
Io invece non posso che sperare che all’esame di giovedì non mi venga chiesto proprio qualcosa scritto in quella pagina, che poi erano due facciate sulla parametrizzazione basata sui quaternioni di rotazione finita.